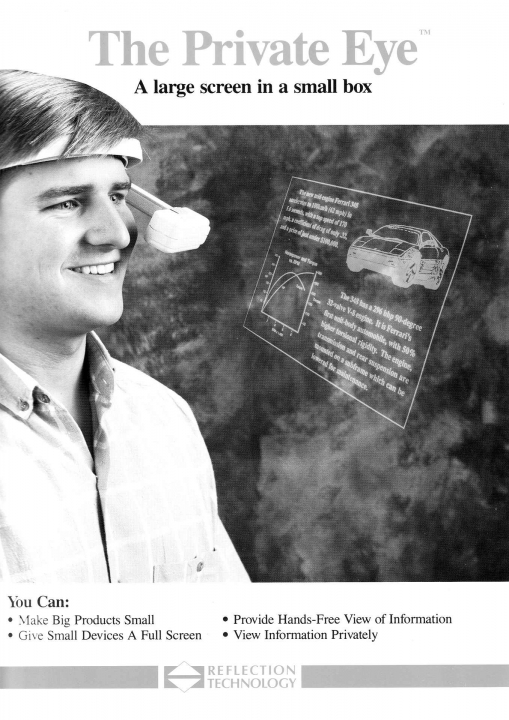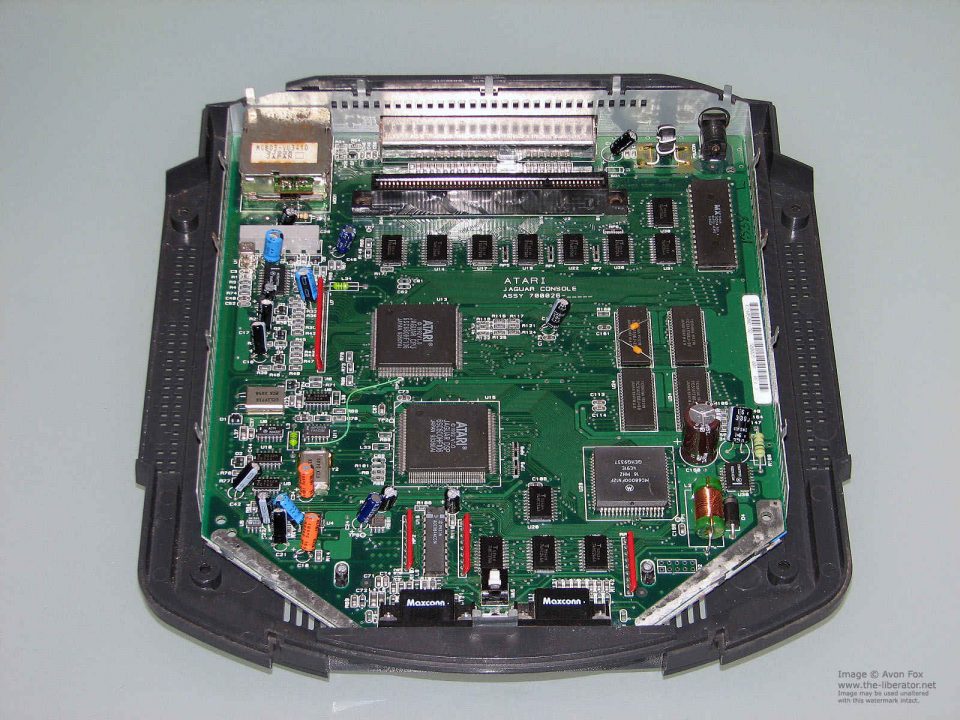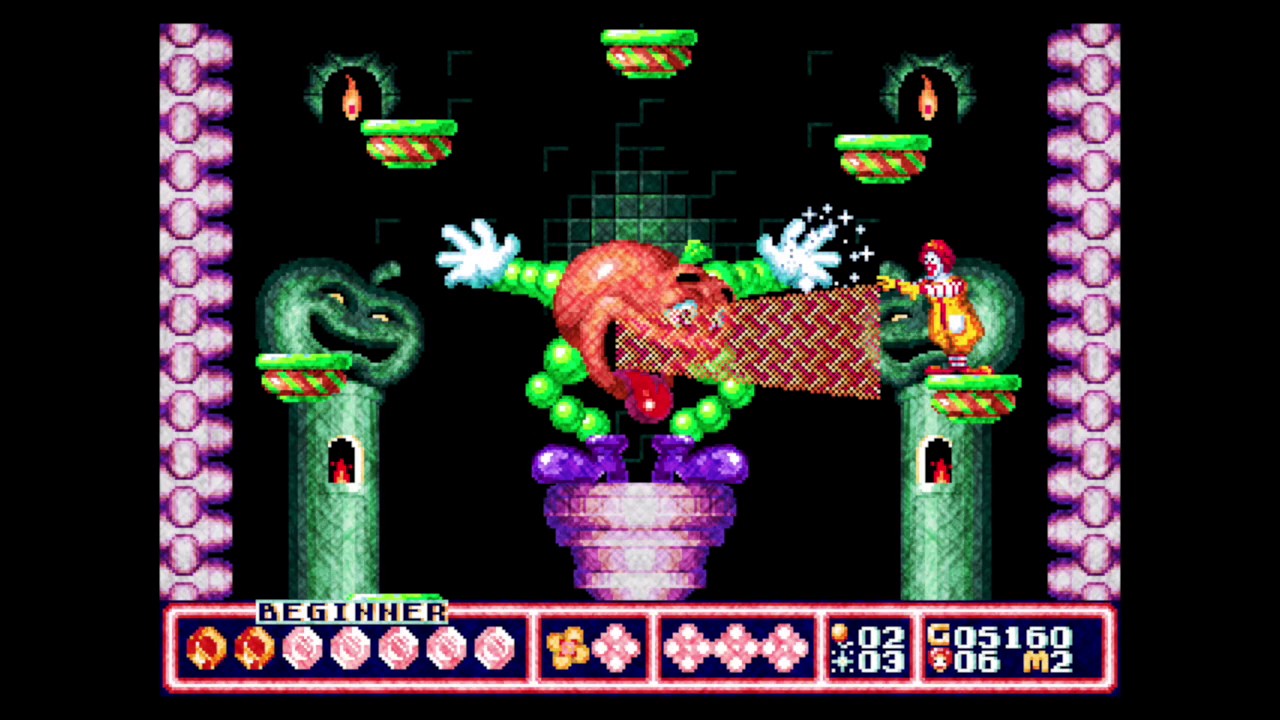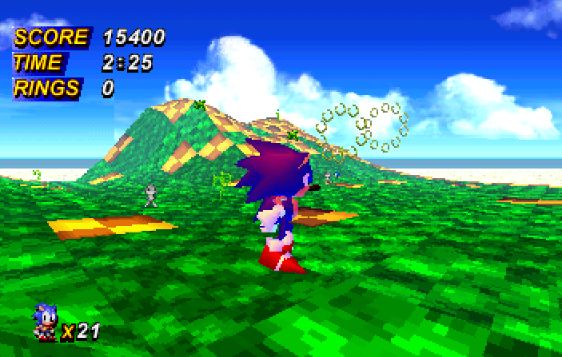L’evoluzione dei controller Pt.2 – gli anni 2000
I controller, dagli arcade alle console casalinghe, hanno fatto tanta strada, passando da controlli digitali a controlli analogici in grado di permettere movimenti a 360°. Quali altre sorprese attendevano i giocatori al volgere del millennio? Controller di precisione assoluta, con un design futuristico e funzioni all’avanguardia? Vediamolo insieme in questo nuovo articolo a continuazione del primo che vi invitiamo a leggere prima di questo.
La generazione 128-bit – la generazione X
Sega, dopo il fallimento del Saturn in Nord-America ed Europa, era decisa a lanciare una nuova macchina da gioco che spezzasse totalmente col passato e per farlo aveva bisogno anche di un controller che offrisse ai giocatori un nuovo modo di giocare i titoli SEGA. Il bianco controller del Dreamcast, che si rifaceva al 3D Pad del Saturn, non sembrava affatto un prodotto SEGA: la disposizione a sei tasti frontali fu abbandonata in favore del layout a rombo, dunque con quattro colorati tasti frontali come PlayStation e Super Nintendo, ma con i classici trigger analogici del precedente pad. Questo controller è in definitiva molto comodo, più piccolo rispetto al suo antenato, anche se non risulta il massimo per lunghe sessioni di gioco: al di là della strana scelta di far passare il cavo dalla parte bassa del controller e non da sopra, fu montata una levetta analogica convessa che, in assenza di una gommina come nel Dual Shock, scivola facilmente dalla pressione del pollice del giocatore, soprattutto quando la mano comincia a sudare dopo lunghe sessioni di gioco; in aggiunta a tutto questo, qualora ci serva, il controller del Dreamcast monta una croce direzionale rialzata, realizzata con plastica durissima e stranamente “iper-spigolosa”, un calvario per chi vuole giocare con gli eccellenti picchiaduro ospitati nell’ultima console SEGA. Tuttavia il nuovo controller per Dreamcast presentava anche due slot, quello frontale indicato per inserire la VMU, ovvero una piccola memory card dotata di un piccolo schermo a cristalli liquidi; non tutti i giochi sfruttarono questa caratteristica (molti giochi mostravano semplicemente il logo del gioco in esecuzione) ma altri invece, come Skies of Arcadia e Sonic Adventure 2, riuscirono a creare una sorta di interazione col gameplay in corso. Nell’altro slot i giocatori avrebbero potuto inserire il Rumble Pack, più indicato visto che, nonostante possa accogliere una seconda VMU, non è possibile vedere il secondo schermo. Nonostante tutto, parte dell’abbandono dello sviluppo su Dreamcast è dovuto in parte anche al controller: che possa piacere o meno, la verità è che il controller presenta soltanto sei tasti quando PlayStation 2 e Xbox ne presentavano otto e dunque, ammesso che fosse possibile fare dei porting dedicati per Dreamcast, era impossibile per la console accogliere dei giochi che sfruttassero più comandi di quelli previsti. Il controller per Dreamcast non è assolutamente pessimo ma sicuramente SEGA avrebbe potuto fare di meglio.
Cos’è? È un meteorite? Un aquila? Un U.F.O.? No! È il cosiddetto “Duke“, il controller originale della prima Xbox! Questo titanico controller, all’apparenza, sembra presentare un layout a rombo come quello PlayStation o Dreamcast (vista anche la vicinanza fra SEGA e Microsoft in quel preciso periodo) ma in realtà, presenta invece il layout a sei tasti simili ai controller di Mega Drive e Saturn ma disposti in verticale! Non tutti capirono questo sistema e il tutto risultava abbastanza scomodo e poco risoluto. Il controller fu nominato “errore dell’anno 2001” da Game Informer, ma Microsoft aveva un asso nella manica: il “Duke” fu messo in bundle con la console in tutto il mondo con l’eccezione del Giappone. Per quello specifico mercato Microsoft disegnò un controller che potesse meglio accomodare le più piccole mani dei giocatori giapponesi e così, su richiesta dei fan, il “Duke” fu presto sostituito dal migliore controller “S“. Con questo controller, il cui nome in codice era Akebono (fu il primo lottatore di sumo non giapponese a raggiungere il rank di Yokozuna), i giocatori ebbero in mano un controller veramente di qualità anche se non poteva essere considerato realmente uno dei migliori: fu scelto un più semplice layout a rombo preciso, come quello del DualShock, ma i tasti “bianco” e “nero” finirono in basso a destra dal set principale (i tasti colorati), rendendo il tutto poco comodo, specialmente quando quei tasti servissero immediatamente. I giocatori Xbox dovevano ancora attendere una generazione affinché ricevessero uno dei migliori controller mai realizzati. Il “Duke” però, fra amore e odio, lasciò comunque una qualche traccia nel cuore dei giocatori, tanto che l’anno scorso Hyperkin rilasciò una riproduzione ufficiale di questo strano controller per PC e Xbox One!
In questo rinascimento dei controller anche Nintendo decise di sperimentare con il joypad da lanciare con la successiva console. Il controller per il GameCube è all’apparenza molto strano ma una volta fatto il callo con le prime sessioni di gioco ve ne innamorerete! Il controller si accomoda perfettamente alla forma della mano, offrendo una saldissima presa, ma sarà l’anomala disposizione dei tasti la vera protagonista: al centro troveremo un bel tastone “A”, mentre alla destra, alla sinistra e al di sopra di questo tasto principale, ci saranno i tasti, rispettivamente, “B”, “X” e “Y”, tutti con una forma diversa. Questa scelta fu presa per permettere al pollice, impegnato principalmente col tasto “A”, di raggiungere tutti i tasti attorno, ma principalmente, secondo Shigeru Miyamoto, per permettere una migliore memorizzazione dei tasti del pad. Insieme a questi tre tasti ne troviamo tasti dorsali e una levetta “C” (in sostituzione dei tasti “C” del Nintendo 64) per un totale di sette tasti. Anche questo controller, come quello per Dreamcast, soffriva per un tasto in meno ma a differenza della sfortunata console SEGA, tramite alcuni stratagemmi, riuscirono ad aggiudicarsi dei buoni e gettonati porting dell’epoca anche con quello strano controller.
Più in là Nintendo produsse per GameCube il Wavebird, il primo controller wireless prodotto da un first party dai tempi di Atari. Il controller, che funzionava con le frequenze radio, mancava della funzione rumble ma risolveva in prima persona il problema dei cavi per terra, avviando così il trend, nella generazione successiva, di includere un controller wireless incluso con la console.
Un po’ come il DualShock, questo controller non ne ha mai voluto sapere di morire o passare di moda, tanto è vero che a tutt’oggi è considerato la quintessenza per giocare a qualsiasi gioco della serie Super Smash Bros.; a testimonianza di ciò esistono le “re-release” di questo particolare controller, nonché il Pro Controller PowerA (ufficialmente licenziato) per Nintendo Switch che aggiunge i tasti “home“, “–” e “+” e un dorsale sul lato sinistro del controller (ovvero l’ottavo tasto mancante nell’originale).
“Se qualcosa funziona, non aggiustarla”: come anticipato nella prima parte, fu questa invece la filosofia di Sony per questa generazione. Il DualShock 2 rimase quasi lo stesso, implementando principalmente i tasti analogici per tutti i tasti frontali e dorsali, offrendo ancora più precisione del già precisissimo DualShock. PlayStation 2 è la console più venduta di tutti i tempi e un controller così funzionale è a testimonianza della qualità di questa superba macchina da gioco.
Eccellenza e motion control
Prima di introdurre il trend dei motion control, che molto caratterizzò questa generazione, vorremo prima ammirare il fantastico controller per Xbox 360. Questa volta Microsoft si superò consegnando una versione rivisitata del controller “S“, con una presa migliorata, un layout a diamante, permettendo al pollice di raggiungere i tasti con più facilità, quattro tasti dorsali come il DualShock, eliminando i tasti “bianco” e “nero“, e un bel “tastone” home che permetteva anche di avviare la console come un telecomando. La ciliegina sulla torta fu rappresentata dal jack per l’auricolare in bundle con la console in modo da connettere i giocatori online via chat vocale; una feature che diventerà obbligatoria dopo questa generazione. Questo controller diventò in poco tempo anche il controller non ufficiale della scena PC proprio per la sua incredibile versatilità e maneggevolezza e ancora oggi, per chi lo possiede sente il bisogno di acquistare la nuova versione per Xbox One, viene ancora utilizzato da moltissimi giocatori per PC di tutto il mondo. I primi controller in bundle con la console avevano la tendenza, dopo un po’ di usi, al drifting, ovvero un input fasullo dovuto ad alcuni residui di polvere del componente della levetta; come la non compatibilità con gli HD-DVD e il “red ring of death“, il drifting fu il risultato della scelta di lanciare la console in fretta e furia ma fortunatamente tutti i problemi relativi ai primi lotti di console furono piano piano debellati, dunque anche i controller successivi al lancio, nonché quelli in bundle con i modelli “slim” e “S“, riscontrarono meno problemi di drifting.
Tuttavia, durante questa generazione non fu di certo questo controller a rubare la scena. Era il 2005, durante il periodo dell’E3, quando un trailer mostrò le capacità dello stranissimo controller per l’allora Nintendo Revolution (senza alcun video di gameplay, giusto per dare un ulteriore senso di mistero), in seguito divenuto Wii: la gente che lo utilizzava imitava azioni di ogni tipo, dal brandire uno spada e uno scudo, illuminare una stanza a mo’ di torcia, dirigere un’orchestra, ma anche azioni più comuni come tagliare ingredienti o pescare. In molti storsero il naso di fronte a questo controller a forma di telecomando ma la verità fu che il Wii Remote (o Wiimote) divenne ben presto, in un epoca in cui i tasti d’azione nei controlli erano otto (dieci se contiamo la pressione delle levette), un controller incredibilmente facile da utilizzare grazie ai suoi motion control. Persino genitori e nonni di tutto il mondo finirono per aver giocato, almeno una volta nella vita, a titoli come Wii Sport, Wii Play e molti altri titoli! Sebbene i titoli party erano quelli in cui era coinvolto più movimento, nonché i migliaia di titoli “shovel-ware” che finirono per riempire il catalogo dei giochi ufficiali Wii, non bisogna dimenticare titoli come The Legend of Zelda: Twilight Princess, Super Mario Galaxy, Metroid Prime 3, Mario Kart Wii, Disaster: Day of Crisis, Mad World o No More Heroes in cui il Wiimote aggiunse realmente un layer di profondità finora inesplorato. Il dominio motion control arrivò e tramontò col Wii ma è bene ricordare che fu un periodo molto particolare, tanto che arrivò a influenzare in un qualche modo anche la generazione successiva: ne sono ovvi esempi gli attuali controller DualShock 4 e Nintendo Switch, nonché il gamepad per Wii U (di cui parleremo più avanti).
Impatto a parte, cosa offre un Wiimote? In alto, insieme al pulsante power, troviamo un D-pad che, nonostante la strana posizione, funge perfettamente come un menù rapido in giochi come The Legend of Zelda: Twilight Princess e come metodo di controllo principale se utilizzato in orizzontale, diventando a tutti gli effetti un controller a là Nintendo Entertainment System visti anche i tasti “1” e “2” sull’altra estremità del controller, diventando un controller perfetto per i giochi platform 2D nonché gli stessi giochi per NES presenti nel catalogo della Virtual Console. Preso in verticale, esattamente sulla linea del pollice e indice troveremo un tasto grande “A” e un grilletto “B“, pronti immediatamente per l’uso mentre, sulla metà, troveremo invece i tasti home, “+” e “–” (da questa generazione i veri sostituti dei tasti start e select); proprio sotto al tasto home, inoltre, vi è un piccolo speaker che riprodurrà alcuni effetti sonori dal gioco in esecuzione. Tuttavia un Wiimote, soprattutto se si vogliono giocare i giochi più belli, non è niente senza un Nunchuck, l’espansione naturale di questo controller: questa impugnatura offre al giocatore una buonissima levetta analogica e due ulteriori tasti, “C” e “Z“, sulla parte alta dell’impugnatura da premere con l’indice. I tasti effettivi, dunque sono sei (quattro se contiamo che “1” e “2” sono difficilmente raggiungibili in modalità Nunchuck), ma è chiaro che tutto ciò che viene a mancare viene compensato dai movimenti e dalle azioni da compiere, sia con il Wiimote che col Nunchuck, anch’esso parte dei motion control. Al lancio il Wiimote, che funge anche da puntatore (dunque un vero e proprio mouse), doveva includere sia accelerometro, che registra principalmente i movimenti, e un giroscopio che ne registra invece la posizione ma alla fine venne incluso solo il primo; più tardi fu rilasciato il Wii Motion Plus, un accessorio (una sorta di cubo) che ultimò definitivamente il controller per questa generazione aggiungendo il giroscopio, ma in seguito i futuri Wiimote furono costruiti con entrambi i componenti all’interno, rinominando il tutto in Wii Remote Plus. L’esperienza dei controlli per Wii furono strani e, tutto sommato, passeggeri ma i motion control sono a tutt’oggi presenti, in misure più o meno incisive (ma sicuramente meno presenti) a seconda dei giochi, come in Splatoon 2 o Super Mario Odyssey.
Per il resto Nintendo offrì un ulteriore controller a otto tasti rinominato Classic Controller, simile a un controller per Super Nintendo, per giocare al meglio i giochi della Virtual Console, specialmente quelli post-NES. Il Classic Controller Pro, che aggiunse principalmente due maniglie (a là DualShock) per una migliore presa, fu invece il metodo principale per giocare a giochi come Goldeneye 007 (2010) o Samurai Warrior 3 (tanto che venne incluso in bundle), sottolineando invece come i motion control, spesso, risultavano superflui e quanto invece servisse un controller semplice per godersi al meglio alcuni titoli.
L’annuncio del Wiimote colse tutti di sorpresa e fra quelli c’erano anche i concorrenti Microsoft e Sony. La prima lasciò perdere totalmente, almeno per l’inizio, in quanto investire immediatamente avrebbe rappresentato un rischio inutile, senza contare il fare la figura dei copioni, e poi l’analizzare con pazienza il trend dei motion control avrebbe permesso lo sviluppo di un set più originale e avanzato; ovviamente stiamo parlando del Kinect ma qui eviteremo di parlarne in quanto, essendo, sì, un metodo di controllo ma non un controller vero e proprio, non c’è nulla da “tenere in mano” e pertanto rimanderemo questa conversazione a qualche altro articolo. Sony invece cominciò a correre ai ripari in quanto, nonostante le critiche mosse al Wiimote, i motion control erano visti come la prossima grande cosa. Inoltre in pochi sanno che Sony aveva il DualShock 3 pronto sin dal lancio ma una causa legale contro la Immersion Corporation, proprio per la feature del rumble, li spinsero a togliere la vibrazione in favore dei motion control per offrire qualcosa di nuovo. Il Sixaxis fu annunciato otto mesi dopo l’annuncio del Wii Remote e in molti videro uno strafalcione del concetto offerto da Nintendo; il tutto fu aggravato non solo dal fatto che durante l’E3 del 2006 Warhawk fu l’unico gioco per PlayStation 3 a mostrare le capacità del Sixaxis ma gli sviluppatori alla Incognito Entertainment si lamentarono del fatto che il controller Sony arrivò soltanto 10 giorni prima dell’evento. PlayStation 3 fu lanciata fra il 2006 e il 2007 (in Europa) e agli imbarazzanti prezzo di lancio fu incluso un controller sconclusionato, le cui motion feature venivano utilizzate pochissimo, senza vibrazione e anche troppo leggero (dunque prono alla rottura in caso di caduta). Ciò che è peggio è che Phil Harrison, l’allora presidente della Sony Worldwide Studios, ebbe da dire che il rumble era una feature obsoleta e che il motion control era il futuro (senza contare che il Wiimote, seppur senza giroscopio, aveva motion control e vibrazione). I problemi per Sony finirono fra il 2007 e il 2008 quando il più efficiente e iconico DualShock 3, che (come abbiamo scritto nel precedente articolo) implementò i grilletti e la tecnologia wireless con batteria al litio ricaricabile, sostituì definitivamente il Sixaxis, finendo così la motion-avventura per Sony… o così sembrava!
La tecnologia Sixaxis finì direttamente all’interno di PS Vita, mentre su PlayStation 3, intenti e decisi a rilasciare un vero e proprio motion control, Sony rilasciò il PlayStation Move. Nonostante ancora scelsero di copiare direttamente ciò che faceva Nintendo, il nuovo controller Sony risultò ben costruito ed ebbe, fra alti e bassi, un buon successo: nonostante i movimenti potevano sostituire l’ausilio di qualche tasto, furono inclusi tutti i tasti di un DualShock intorno al controller e i primi giochi dedicati al Move, che dovevano essere giocati con la nuova ridisegnata Eye-toy, mostrarono degnamente il potenziale di questi controller. PlayStation Move, durante l’era della PlayStation 3, non ebbe il successo sperato ma questi furono interamente implementati per l’utilizzo di PlayStation VR, e dunque ancora oggi utilizzati dai giocatori di tutto il mondo.
(Nota: il Sixaxis non è presente in questa galleria in quanto differisce soltanto per la scritta “DualShock 3” sul lato alto del controller. Al di là dei motion control, che ovviamente in foto non si vedono, i due controller sono esteticamente identici.)
La mid-gen e i controller odierni
Con Wii Nintendo riuscì ad avvicinare molti casual gamer allontanando però molti hardcore gamer che nel frattempo, intenti a provare il gaming in HD, si spostarono verso Xbox 360 e PlayStation 3. Wii U fu rivelata durante l’E3 del 2011 e con essa il proprio “tablet controller”. Dopo una creativa disposizione dei tasti su Gamecube e un accantonamento generale durante la precedente generazione, Wii U proponeva un ritorno alle origini con una disposizione di tasti più vicina al Classic Controller Pro per Wii, un giroscopio e un touch screen per, letteralmente, vedere i giochi da una prospettiva totalmente diversa; insieme a tutto questo fu incluso un microfono, degli speaker e una telecamerina sulla parte alta dello schermo, dando come l’impressione che fosse una specie di Nintendo DS fisso. Nonostante le premesse, in pochi riuscirono a immaginare realmente un utilizzo innovativo del touchscreen, col risultato che pochissimi giochi sfruttarono al 100% le sue caratteristiche, come Pikmin 3, Splatoon ma soprattutto Super Mario Maker; insieme al controller, ad affondare fu l’intero sistema in quanto i developer difficilmente trovavano un vero utilizzo per il tablet controller, ma ciò che è peggio è che il pubblico non capì realmente cosa fosse il Wii U (un’espansione del Wii? una nuova console? Ne parleremo qualche altra volta).
In tutta questa grande confusione, il nuovo controller non sembrava piacere a tutti: c’era a chi piaceva e c’era chi lo odiava, e fra quelli c’erano sicuramente gli hardcore gamer, proprio quelli che la compagnia di Kyoto sperava di richiamare a sé. Fortunatamente per Nintendo, che si assicurò in ogni caso di rendere i precedenti Wiimote compatibili per il nuovo sistema, lanciò con la console anche il più versatile Pro Controller, molto più simile a un controller per Xbox 360. La particolarità di questo controller, come per il tablet, sta principalmente nel fatto di avere le levette analogiche allineate, entrambi sopra la parte inferiore in cui vi è il D-pad e i quattro tasti principali; in tutto questo, come ormai tutti i controller di quest’epoca, vi sono quattro tasti dorsali di cui due trigger. Il Pro Controller fu indubbiamente una mossa verso la direzione giusta ma, come sappiamo, non bastò per far spiccare Wii U fra Xbox One e PlayStation 4 lanciate l’anno successivo. L’esperienza di Wii U, anche in ambito di sistema di controllo, fu di grande aiuto in seguito per coniare Nintendo Switch.
Il nuovo controller per la Xbox One è una vera e propria evoluzione del già ottimo controller per Xbox 360, riportando in auge tutto ciò che rese grandioso il precedente controller, migliorandolo in maniera esponenziale. In seguito, Microsoft rilasciò anche l’Elite Wireless Controller con la quale, grazie a un kit dedicato, è possibile personalizzare il proprio controller con tasti programmabili sul dorso e anche sostituire levette e D-pad, offrendo un grado di personalizzazione mai visto in ambito controller.
Sony invece, forse anche un po’ a malincuore, sostituì l’ormai vecchio design del DualShock con uno nuovo più rotondeggiante, moderno e realmente all’avanguardia. Insieme alle novità del touch pad, dei sensori di movimento correttamente implementati e il led sul dorso del controller, il nuovo controller della PlayStation 4 si adatta ai tempi moderni offrendo al giocatore un immediato tasto share con la quale è possibile caricare sui social network i momenti salienti del proprio gameplay. In quanto a precisione, il controller per PS4 ha un retaggio che va indietro sino al primo DualShock, il che è senza dubbio un sinonimo di garanzia in quanto qualità dell’immissione degli input di gioco.
La natura ibrida di Nintendo Switch ha invece portato al concepimento di un controller formato da due pezzi, simile nell’esecuzione al Wiimote e il suo Nunchuck ma ben lontano dal suo concetto interamente focalizzato nei motion control. I due Joy-Con, sia in modalità portatile che in modalità fissa, offriranno al giocatore la tipica disposizione a diamante ormai tipica dei controller Nintendo, mentre le levette, a differenza del gamepad per Wii U o del suo Pro Controller, stavolta si presentano disallineate per permettere tramite un solo set di Joycon la possibilità di giocare in due giocatori semplicemente tenendo il controller in orizzontale; in tutto questo i controller sono stati muniti di accelerometro, giroscopio e la nuovissima feature HD Rumble, un particolare tipo di vibrazione in grado dare un layer ancora più profondo di realismo (tipico è l’esempio delle biglie in 1 2 Switch). I Joy-Con, purtroppo, si sono resi protagonisti di uno spiacevole malfunzionamento, ovvero quello del drifting dopo circa un anno assiduo di gameplay ma Nintendo, per fronteggiare il problema, si è offerta di riparare i Joy-Con anche dopo il superamento della data di garanzia.
Nel caso voleste evitare il problema del drifting, nonché prendere in mano un controller più tradizionale, allora vi converrà passare al più preciso Pro Controller che offre le stesse feature dei Joy-Con (persino il riconoscimento degli Amiibo) ma con una presa decisamente più comoda e rilassata. In più è presente un D-pad in quanto scartata nei Joy-Con per permettere due pezzi perfettamente speculari e che si prestassero al gioco in due giocatori. Se non vuoi essere considerato un principiante a vita allora ti converrà passare al Pro Controller stasera stesso!
Futuro?
Finisce così la nostra strada che ci ha portato dai joystick ai joypad ma ovviamente, nonostante gli headset VR e chissà quali future diavolerie, i controller saranno destinati ad accompagnare per sempre il giocatore. Quali saranno le future innovazioni per i controlli? Come si controlleranno i videogiochi di prossima generazione? E in tutto questo: qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere nei commenti!