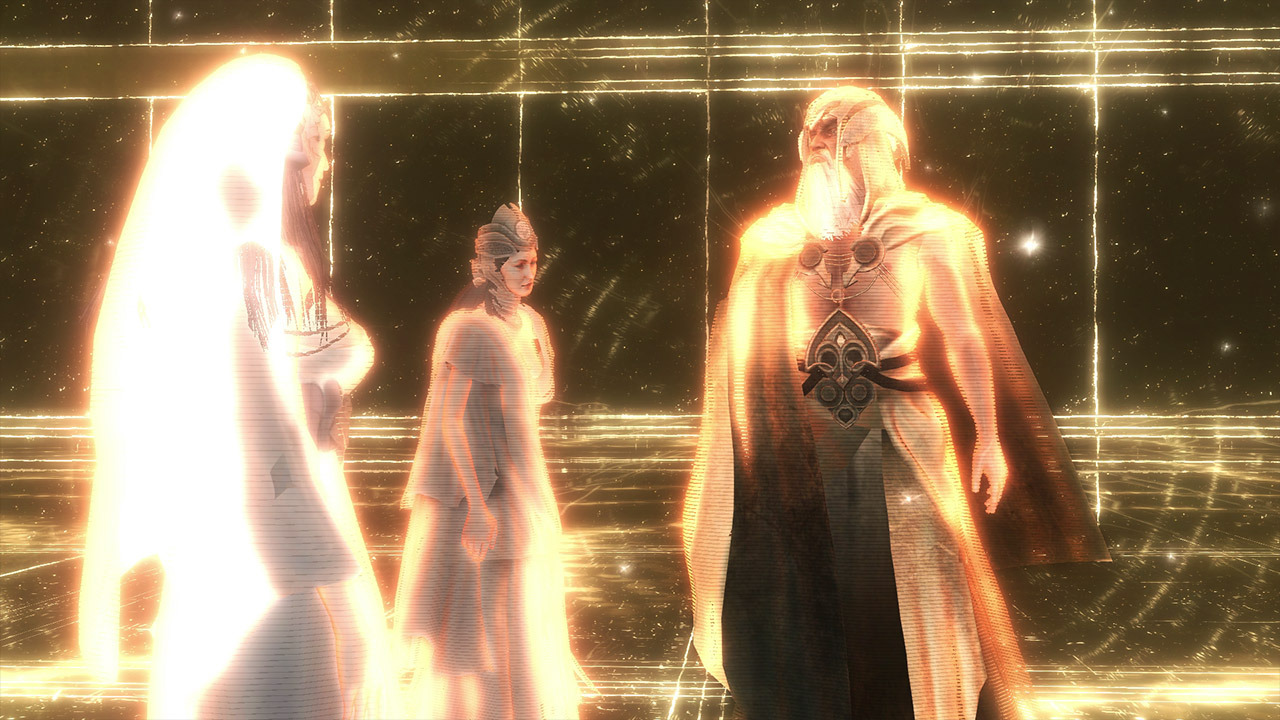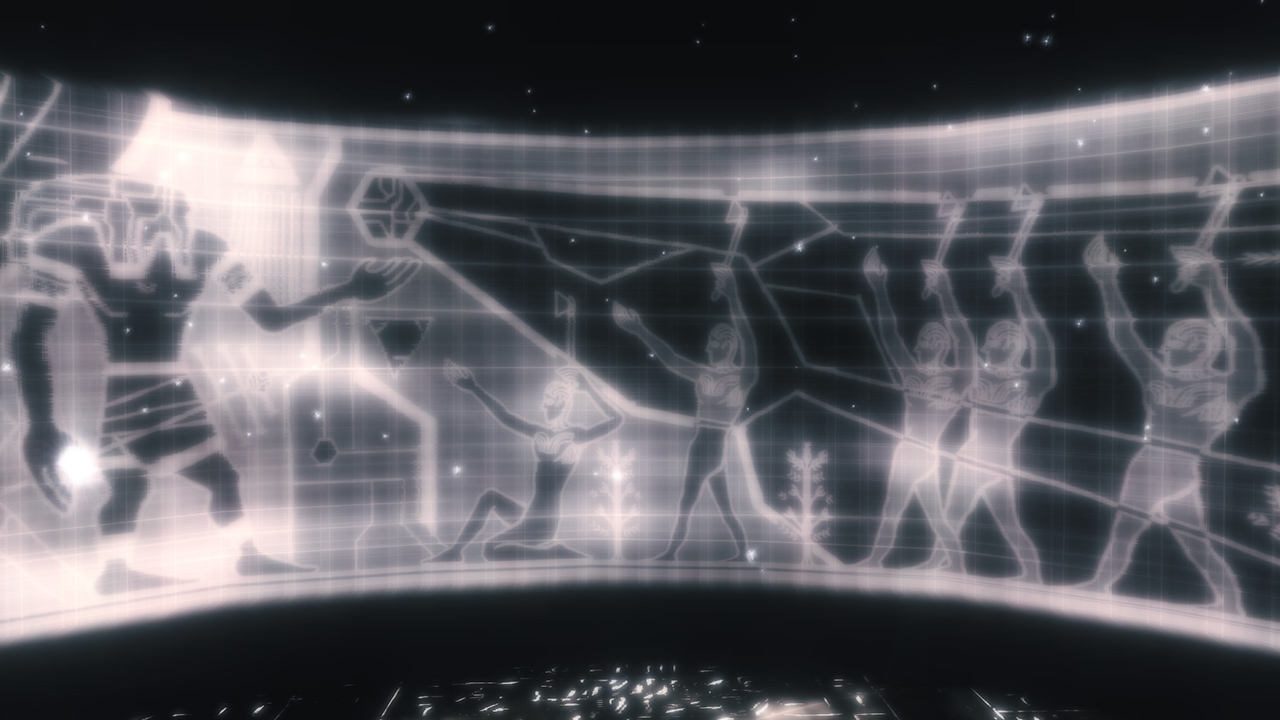C’era una volta alla… Milan Games Week
Questo è un articolo diverso dal solito. Normalmente questa rubrica cerca di sviscerare tutte le tematiche possibili del mondo videoludico (da qui il nome 42), ma oggi no. Oggi vi propongo un racconto personale della mia prima esperienza alla Milan Games Week, una fiera che ho sempre voluto visitare ma che si è scontrata con le mie aspettative, quelle di un sognatore capace di meravigliarsi per qualunque cosa, anche di una “auto blu”.
Un nero mare di infinita gente
Saltando a piè pari il lungo viaggio che mi ha portato in quel di Milano, dopo lo straniamento causato da due palazzi adiacenti alla fiera, ecco che finalmente vedo l’ingresso della Milan Games Week 2019. Il primo pensiero è andato verso il tesseratto della società odierna, formato da tante piccole menti accomunate da un solo pensiero: la f…ortuna di trovarsi nel centro nevralgico del videogame in Italia. In poche parole, gente, gente e ancora gente. Incredibilmente, il paragone più efficace per far rendere l’idea è quello del casinò, un luogo chiuso, ipnotico, strapieno di luci e belle ragazze. Tralasciando il piccolo dettaglio che non viene servito da bere gratis, tutto risulta abbastanza similare, creando così l’effetto Trainspotting: pochi minuti diventano ore e, improvvisamente, è tutto finito. Ma andiamo con ordine.
Partiamo con lo stand di Cyberpunk 2077, per quanto mi riguarda il titolo che aspetto di più il prossimo anno. Stand carino come quelli di JoJo ma povero di contenuti come Pomeriggio Cinque. Ovviamente niente demo giocabile (ci mancherebbe) e con questa ultima frase potrei chiudere qui l’articolo. Ma mi faccio forza, recupero dalla delusione e proseguo.
Si, perché di stand ce ne sono a bizzeffe, alcuni con ottime trovate come in quello di FIFA 20, allestito con una gabbia al cui interno era possibile testare le nostre qualità di calciatori professionisti a parole. Purtroppo non sono riuscito a giocare fisicamente (avrei umiliato tutti quanti…) ma digitalmente si, visto che da diversi anni gioco al calcistico EA dopo una pre-adolescenza passata in Konami. La novità più eclatante è senza dubbio la Modalità Volta, come si evinceva dalla gabbia lì fuori: un FIFA Street dentro FIFA 20 è quello che Electronic Arts ci propone e nonostante funzioni, in qualche modo non mi ha entusiasmato. Inutile dire come le vere novità cominceranno ad apparire l’anno prossimo con l’avvento della nuova generazione, ma la stagnazione comincia a farsi sentire ed è per questo cari amici, che sono tornato da PES. Anche per Pro Evolution lo stand era ben presente ma visto che avevo provato abbondantemente la demo e il gioco completo precedentemente sono semplicemente passato oltre.
Le prove effettuate con diversi titoli sono state abbastanza interessanti, grazie anche alla scoperta di app atte alle prenotazioni dei vari test… ammesso e concesso che ci si riesca, certo.
L’unica prova prenotata con successo è stata quella di Nioh 2, seguito del fortunato RPG a tinte “souls like” di Team Ninja. Giocare con qualcosa che uscirà solo tra qualche mese è interessante per diversi aspetti: il primo è quello di sentirsi privilegiati, toccando con mano qualcosa che la gente comune vedrà solo nel prossimo futuro. Tralasciando questi finti sensi di onnipotenza, la prova è utile anche per poter discutere delle sensazioni preliminari con altri utenti e con gli sviluppatori (che ovviamente non erano presenti ma mi piace pensare che osservassero i nostri gameplay in gran segreto).
Terzo e ultimo punto, puoi suggerire cambiamenti o miglioramenti che ovviamente non verrebbero presi in considerazione a pochi mesi dal lancio. E quindi Nioh 2? Risulta molto simile al precedente capitolo, con la differenza che il nostro alter ego non è più un personaggio predefinito ma “customizzabile” e la possibilità di trasformarsi in un potentissimo Yokai, anche se ancora quest’ultima non sembra essere contestualizzata narrativamente, almeno per ora. Inoltre non vi è stato modo di testarne eventuali malus, un po’ come la trasformazione “draconica” dei Dark Souls ma, in ogni caso, è una soluzione che regala gran soddisfazione.
Non accontentiamoci
Passiamo a un gioco molto simile: Grid. Battute a parte, il nuovo remake Codemasters può diventare una delle migliori sorprese dell’anno, con quel sistema Nemesi che tanto ricorda (ma forse solo per omonimia) il tanto decantato La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor o L’Ombra della Guerra, ma applicato ai piloti. Effettivamente l’intelligenza artificiale degli avversari sembra rivaleggiare con i Drivetar dei Forza Motorsport e Horizon, anche se è ancora molto presto per sbilanciarsi. Il titolo sembra ricordare per diversi aspetti il precedente Grid: Autosport, un ibrido simulativo-arcade che può si aprire verso un pubblico molto vasto ma che rischia di non accontentare nessuno. Essendo un grande fan dell’originale Grid, non vedo l’ora di toccarlo con mano, per cui attendevi ben presto una recensione tra queste pagine.
Ma altro titolo molto atteso non poteva che essere il remake di Final Fantasy VII, progetto misterioso ma ora più concreto che mai. Il titolo si presenta molto bene, con quel gameplay ibrido che ha inizialmente suscitato molti dubbi ma che in realtà si rivela essere la scelta più azzeccata. Siamo comunque nel 2020, la gente è abituata all’azione e, per quanto un sistema a turni possa dare quel tocco di tatticismo in più, non riesce a regalare la giusta dose di adrenalina di cui siamo assuefatti nell’età contemporanea. Effettivamente, vedere un titolo giocato non so quanti anni fa in questa veste totalmente rinnovata fa abbastanza impressione: la cosa interessante, almeno per quanto mi riguarda, è che quando avevo l’età in cui la vita risulta molto semplice, il gioco, mi sembrava così, con la stessa veste grafica. In poche parole, era come se l’immaginazione mettesse del suo, producendo elementi che l’hardware non riusciva a riprodurre. Un po’ come il viso di Snake in Metal Gear Solid.
Saltando altri episodi discretamente interessanti, sono rimasto sorpreso dello spazio dedicato al mondo degli Indie, alcuni dei quali veramente interessanti come Forgotten Hill Disillusion e altri lavori che puntano non solo al divertimento in senso stretto ma in grado di approcciare l’apprendimento o il management in maniera innovativa. Inutile dire come alcuni Indie erano pressoché scadenti, nonostante le buone idee di base: l’impressione è che alle volte non si sfrutti pienamente il palcoscenico di una fiera così importante, mancando totalmente il bersaglio. Si può avere l’idea migliore del mondo ma se non si sa esprimere diventa essenzialmente come uno sputo in pieno oceano: è vero che il livello del mare aumenta, ma è del tutto irrilevante.
Sugli e-sport dedicherò probabilmente un articolo (più serio) a parte; del resto è un fenomeno interessante e che sta evolvendo precipitevolissimevolmente e uso questa parola semplicemente perché non ho mai trovato occasione per farlo.
La Milan Games Week arriva al termine dopo aver visto cose che voi umani non potreste immaginarvi, aver incontrato tantissime persone e nuove realtà, aver provato titoli in anteprima e camminato per decine di chilometri. Il risultato: potrebbe essere fatto molto di più. Non fraintendete, è stata un gran bella esperienza, eppure il sentore che in qualche modo ci si accontenti permane. Forse servirebbero più anteprime, magari internazionali, ospiti di maggior livello ed eventi in grado di far partecipare più attivamente il pubblico.
La scena videoludica italiana sta crescendo, anche grazie a questa fiera ma forse, è arrivato il momento della sferzata decisiva e dare lustro a un settore che nel nostro paese non ancora apprezzato come dovrebbe.